Sono solo.
Solo come una malattia dopo che ha ucciso il paziente. Come un diario che nessuno leggerà mai. Come queste lettere che non ti spedirò mai.
Solo come un vecchio.
Ci ho provato, sai? Dopo che tua nonna se ne è andata, ho tentato. Ma un po’ alla volta, qui intorno, sono morti tutti. Non mi sono arreso. Non potevo ma più di tutto, non volevo. E allora? Allora ho cercato i compagni di guerra, quei ragazzi con cui una vita fa ho attraversato mezza Europa. Indovina?
I più fortunati sono morti. Quelli che sono rimasti… loro non sapevano chi io fossi. L’età ha stracciato la loro mente, ha diluito il tempo fino a farlo diventare una palude. Annegano senza saperlo. Un centimetro alla volta l’acqua marcia in cui sono immersi salirà fino a coprire loro la bocca, il naso. Scivolerà giù per la gola, inonderà i polmoni, comprimerà il cuore: non resterà niente della loro memoria. E forse, a quel punto, moriranno.
E io? Io sono condannato a restare qui, a sopravvivere. Non posso ma più di tutto non voglio andarmene perché ci sono cose che devo guardare, che devo capire.
Cose che sono diverse da quello che sembrano e che adesso, dopo tanto tempo, dopo che tutti se ne sono andati, mi tengono compagnia.
1.
Le ombre sono ricordi che non trovano la via di casa.
Lo diceva sempre mio nonno, nei pomeriggi passati alla finestra dello studio, gli occhi incollati sulla parete scorticata del cimitero. Era come pelle vecchia, quel muro. In alcuni punti talmente sottile da esporre tendini e ossa.
Qualche volta mi sedevo accanto a lui. Prendevo lo sgabello, lo trascinavo senza far troppo rumore e poi mi ci appollaiavo sopra. Come i corvi, quelli che si riposano tra un tuffo e l’altro tra le lapidi. Osservavo il cimitero e poi guardavo lui. Il profilo serio, i riflessi del giorno sul cranio quasi completamente calvo. Gli occhi fissi su qualcosa che non c’era. Forse guardava il passato. Forse pensava al futuro. Forse.
Ecco, vedi?
Diceva il nonno ogni volta che una schiena curva di dolore scivolava lungo la pelle itterica del muro e si dirigeva verso il grosso cancello in ferro battuto che separava i morti dai vivi.
E io guardavo. Guardavo e non capivo. A volte immaginavo che il cancello si piegasse fino a rompersi, che quella rovina fosse il preludio di qualcosa di orribile. Morti che camminano. Ma poi rimettevo a fuoco la realtà e tutto era ancora lì. Immobile. Come il nonno.
Hai visto? Mi chiedeva poi con un’urgenza strana nella voce.
Cosa, nonno? Cosa devo vedere? Avrei voluto dirgli. Invece annuivo, serio come solo un ragazzino di dodici anni sa essere.
Ho visto, nonno. E invece tentavo di capire cosa cercasse quel vecchio vedovo che aveva fatto di tutto per tenersi stretta una casa troppo grande e troppo complicata.
Le persone? Il loro dolore? Cercava nei passi trascinati dei visitatori un po’ di quella sofferenza che lo incatenava lì, tra ricordi accatastati male?
No. Il nonno non guardava le persone, a lui le persone non interessavano. Il nonno guardava le ombre.
Te lo sei mai chiesto?
Ti sei mai chiesto a cosa serve invecchiare se non c’è più nessuno a ricordare chi eri? A raccontare cosa hai fatto, cosa hai visto, come hai vissuto?
Senza le memorie degli altri non siamo niente. Niente. Pensaci. Pensaci quando butterai via un’amicizia per una cazzata, quando chiuderai una storia senza un vero motivo.
Il male che facciamo trasforma i ricordi in ombre. E le ombre sono ricordi che non trovano la via di casa. Perciò, alla fine, siamo il cattivo odore di un litigio mai risolto. La puzza di una risposta scortese.
È come mangiare un cattivo dolce a fine pasto. Ti resta la bocca sporca e non conta niente tutto quello che è venuto prima. Sarà quel sapore – quel sapore schifoso – che sentirai sulla lingua quando ripenserai a quel pranzo e alle persone che erano con te. Non le risate, non il vino buono. Non le cose belle che sono successe o che vi siete raccontati. Ma solo quel persistente, orrendo, sapore.
Ecco. È così. È proprio così. Fare del male è come essere un cattivo dolce a fine pasto.
E io sono stato una delle torte più disgustose che abbiano mai servito.
Che tu ci creda, o no.
2.
Pochi anni dopo ci trasferimmo. Forse qualcuno litigò o più semplicemente quel vecchio paese di provincia non era più adatto alle ambizioni di mamma e papà. Fatto sta che mi allontanai dal nonno, da quella casa e dal cimitero. Mi mancava il nonno? Non lo so. A volte mi sembrava di sì ma poi pensavo al cancello, al muro giallo, alla processione di persone tristi.
Sì. Forse il nonno mi mancava. Ma quando ripensavo al cimitero… ecco, be’. Preferivo rinunciare a entrambi.
Ci sentivamo ogni tanto, mentre gli anni passavano veloci. Ma erano conversazioni brevi, scomode. Poche sillabe che mi rimbalzavano addosso, che strisciavano controvoglia fuori dal telefono.
Stai ancora guardando quel muro, nonno? Chiedevo.
Non rispondeva mai. Ma immaginavo il suo fiato condensarsi sul vetro della finestra. E io mi ritrovavo ancora lì, sullo sgabello, mentre lo osservavo sporgersi in avanti. Il collo che si allungava per sbirciare oltre la finestra ogni volta che una portiera si apriva e poi si chiudeva liberando un nuovo carico di dolore.
Allora ci salutavamo, intrappolati in una routine silenziosa che bloccava entrambi.
Hanno installato dei lampioni, sai? Mi aveva detto l’ultima volta.
Dove? Gli avevo chiesto, stupito da quella confidenza inaspettata, sorpreso dal tono eccitato.
Sulla strada del cimitero. Il nonno si era fermato un attimo, come per prendere fiato dopo una corsa. Adesso ci sono le ombre anche di notte. Ci sono sempre.
Quattro giorni dopo quell’ultima telefonata – un mese fa – mio nonno è sparito.
Come fa una persona a sparire? Come fa a svanire senza lasciare traccia? La burocrazia è piena di risposte a queste domande.
Forse è un allontanamento volontario. Forse è il primo episodio di una demenza senile latente. Forse è uscito e non ha più trovato la strada di casa. Forse. Forse. Forse.
Tutti sinonimi di una realtà terribile ma più semplice da raccontare: a nessuno interessa davvero. Perché se un vecchio solo, un vecchio che ha perso la figlia e il genero in un incidente, un vecchio il cui unico nipote vive a migliaia di chilometri di distanza, be’, se un vecchio così sparisce, tutto sommato, ha fatto un grosso favore a tutti quanti.
Ma non a me. Perché quando mi hanno chiamato fregandosene del fuso orario e svegliandomi in piena notte per vomitarmi addosso quattro parole orribili: “Suo nonno è sparito”, ecco quando questo è successo mi è rimbalzata in testa una sola frase: le ombre sono ricordi che non trovano la via di casa.
Era diventato così anche mio nonno? Un’ombra? Un ricordo che avevo ignorato per quasi vent’anni e che adesso aveva smarrito la via di casa? E la sua sparizione aveva a che fare con la nostra ultima telefonata, con quella strana frase: “Adesso ci sono le ombre anche di notte. Ci sono sempre.”? Tante, troppe domande. E non potevo accontentarmi di ipotesi. Non potevo accontentarmi di tutti quei forse che mi avevano sputato contro con poco tatto.
Per questo sono tornato.
Il dolore non si supera.
E al dolore non ci si abitua. Mai.
A volte, se si è fortunati, penetra talmente a fondo da illuderci di averlo affrontato e sconfitto.
Ma non è così. Il dolore è lì. Basta un profumo, un odore, un colore. Un’immagine banale, un frammento di memoria. Ed eccolo. Ritorna. Risale dalle profondità, distrugge quello che incontra sul suo cammino e finisce con l’occupare tutto lo spazio che trova.
L’amore invece finisce. Può sfocarsi diventando altro, può estinguersi quando inciampa nella morte. Il dolore, no. Il dolore sovrascrive tutto. Tutto.
Perciò non ci resta che contemplarlo. Osservarlo da lontano per poi avvicinarci, un passo dopo l’altro.
Ecco. È in quel momento che scopriamo una cosa tanto semplice quanto sorprendente: il nostro dolore non è solo nostro. E quello degli altri non è solo loro.
È tutto intorno a noi. Un potente collante di vite perse, di occasioni mancante, di lacrime, di sospiri, di assenze.
Un’energia che attrae.
Come la luce fa con le ombre.
3.
La casa è più grande di come la ricordavo e di certo conciata peggio. La siepe, un tempo alta quasi due metri e di un verde brillante, adesso è ridotta a un groviglio rinsecchito. Un’edera tenace l’ha soffocata prima di morire a sua volta, forse avvelenata o forse uccisa dalla siccità. A guardarla, quella siepe, sembra di sbirciare un passato estinto fatto di fossili legnosi e di errori.
Il portico è pericolante. Le due colonne che lo sorreggono hanno risentito dell’umidità e della mancanza di manutenzione. Sono sbrecciate in più punti, l’intonaco scrostato, alla loro base mucchietti di tegole frantumate. L’intero tetto del portico è come l’ala bucherellata di un enorme pipistrello e di certo quando piove si formano dappertutto pozzanghere pastose di calce umida e terriccio. Vedo le orme di quelle pozze. Macchie color pastello, come un set di trucchi andati a male. Strati di solitudine e di dolore che si accumulano uno sopra l’altro mescolandosi alla polvere.
Dentro la casa era ancora peggio. Non ho osato scendere in cantina ma mi ci è voluta quasi una settimana per mettere un po’ d’ordine in salotto, in cucina e nella camera da letto. Sei giorni di duro lavoro per ricavarmi uno spazio tra tutti quei ricordi ammucchiati. Poi mi sono trasferito, al piano terra. Volevo cercare qualcosa che potesse aiutarmi a capire, trovare quelle risposte che non sembravano interessare a nessuno.
Però ho aspettato altri due giorni prima di esplorare lo studio del nonno. Provavo la stessa incertezza che si ha quando si deve inghiottire una medicina cattiva: sai che ti farà bene ma proprio non vuoi sentirne il sapore sulla lingua. Alla fine sono entrato. Se tutta la casa era infestata da un persistente abbandono, nello studio il tempo sembrava essersi fermato.
La scrivania marrone scuro. I libri. Centinaia di libri sugli scaffali. Tutti al loro posto, dove erano sempre stati. Ogni cosa sembrava congelata in un’istantanea fatta di polvere e memorie incustodite. Poi la sedia. Lo sgabello su cui mi sedevo da ragazzo. La finestra.
E oltre la finestra, il cimitero. Incombeva sulla strada come una malattia: il muro giallo era esattamente come lo ricordavo. Per un attimo mi sembrò di non essermene mai andato davvero.
Solo una cosa era diversa: il nonno aveva tolto le tende. Forse doverle aprire ogni volta era diventata una distrazione, un fastidio che rubava tempo alla sua caccia alle ombre?
Tre giorni dopo – due settimane fa – mi sono seduto davanti a quella finestra. Ed è stato allora che per la prima volta ho visto l’ombra.
È successo nel tardo pomeriggio. Ero seduto, distratto, la finestra aperta nel tentativo di alleggerire l’aria pesante dei ricordi. Cercavo di pensare, di capire. Cercavo di colmare l’enorme distanza che si era creata tra mio nonno e il resto del mondo. Perché era sparito? E dov’era adesso? Era… vivo?
E pensavo alla casa. A come doveva essere stato per il nonno vivere in una specie di mausoleo morente. Tutte le cose guaste che avevo visto, cose come la siepe e il portico, disegnavano una geografia di sofferenza che mi faceva male. In quella casa era cresciuta mia madre. In quella casa si erano cristallizzati i primi ricordi di mamma e, in qualche maniera, da quella casa ero nato anche io. Come aveva fatto il nonno a lasciar andare tutto? Cosa lo aveva allontanato da tutto quello che di buono c’era lì intorno? Pensavo, senza guardare.
Perciò non ho visto la macchina parcheggiare. Non ho sentito la portiera aprirsi e poi chiudersi. Ricordo solo di aver intuito qualcosa, a un certo punto. Un movimento che accarezzava il mio campo visivo. Ho spostato lo sguardo seguendo le tracce di alcuni passi: mi attirava il rumore di cuoio sulla ghiaia.
Un’anziana signora, capelli gialli, il cappotto anche se faceva molto caldo, una gonna scura, scarpe nere con un tacco basso. Camminava curva, impegnata in una lenta processione privata lungo il muro del cimitero. Il sole la colpiva su un fianco, di taglio, proiettandone la sagoma sottile. Sorrisi senza allegria: quel bizzarro inseguimento mi incuriosiva. Ma era anche triste vedere come due cose così intime con una donna e la sua ombra fossero destinate a non ritrovarsi mai. Almeno non lì, su quel muro.
Poi è accaduto qualcosa di strano. La distanza tra la donna e l’ombra aumentava e aumentava ancora, un passo dopo l’altro. Sembrava che il mondo venisse riavvolto troppo in fretta. Mi ha colpito una vertigine.
Mi sono avvicinato alla finestra, ho allungato il collo, superato il davanzale. Fuori c’era un odore umido, palustre. Come di acqua stagnante.
La donna era sparita tra i cespugli che anticipavano l’ingresso del cimitero ma la sua ombra era ancora lì.
Immobile. Come scolpita sul muro. Come se un calore troppo forte – o un gelo insopportabile – l’avesse inchiodata tra le macchie di intonaco scrostato. Ho riconosciuto i ricci della donna, la sagoma del cappotto, il profilo delle braccia lungo i fianchi.
Ho affilato lo sguardo, messo a fuoco. Le mani stringevano l’infisso che ha risposto con un piccolo schiocco. Il mio respiro era pesante, affaticato come se mancasse l’aria e ho sentito la puzza di acqua marcia farsi più forte.
Sul muro del cimitero qualcosa ha vibrato. L’ombra si stava muovendo ma invece che ricongiungersi con la vecchia, ho intuito che si stava voltando verso di me. Ho sentito un fischio prima lontano e poi sempre più vicino. Cresceva tutto intorno, si insinuava tra le orecchie cercando di raggiungere il cervello.
Ho chiuso gli occhi, chinato la testa. I denti stretti, piccole schegge di legno che si conficcavano tra le dita.
No, ho mormorato prima di sollevare lo sguardo.
Ma l’ombra non c’era più. O, se c’era, il non riuscivo a vederla.
Poi c’è la rabbia.
Una rabbia che tu non hai mai conosciuto perché ancora non ne hai avuto il tempo. Qualcosa che fermenta tra le pieghe degli anni vissuti. Che si fa più forte, che cresce insieme alle rughe.
Come fosse vino. Una bevanda il cui aroma viene arrotondato da tutti i dolori che lo scorrere del tempo ti butta sulle spalle.
Invecchiare non vuol dire rassegnarsi alla vita. Vuol dire diventare più cattivi, arrabbiati. Per le cose che ci sono state tolte e per quelle che abbiamo capito troppo tardi. Per i torti fatti senza poi chiedere scusa. È come essere scuoiati, uno strato alla volta. Prima la pelle, poi i muscoli, lo scheletro. Alla fine si resta nudi, senza più carne: creature fatte di collera e rimpianti.
Se avessi scoperto prima il potere del dolore, credi che sarei rimasto qui? Se avessi capito cosa fare, credi mi sarei limitato ad andarmene?
No. Ovviamente no. Ma sono vecchio, arrabbiato. E la rabbia, se non la usi bene, è una forma di vigliaccheria.
E poi c’è un’altra cosa. Ti ho scritto che mi sento solo. Che sono solo.
Ma anche tu, lo sei.
Non è vero?
4.
Cosa avevo visto? L’inquietudine del passato in quella casa che cercava di allungarsi dalla mia infanzia fino al presente? Un’allucinazione? Senso di colpa? O avevo visto davvero qualcosa, sul muro?
Le ombre sono ricordi che non trovano la via di casa. Se mio nonno aveva ragione, di chi era quella memoria smarrita?
Quella sera stessa mi sono seduto di nuovo. Ho preso una vecchia bottiglia che mio nonno teneva tra i libri: era convinto che le idee degli scrittori, i loro pensieri, fossero capaci di impregnare il liquore. Ho tolto il tappo. Ho bevuto due, forse tre volte.
Ho aperto la finestra, era una sera fresca. I profumi della tarda primavera entravano nella casa cercando di sovrastare l’odore stantio di memorie andate a male. I lampioni trasformavano la strada in un fiume giallognolo. Tutto intorno, silenzio.
La luce di uno dei lampioni ha vibrato, si è spenta. Quando si è riaccesa, l’ombra era lì.
Ho smesso di respirare mentre di nuovo l’odore di palude saliva dal terreno, si arrampicava sul muro di casa, scavalcava la finestra e mi scivolava in gola.
Chi sei? Ho sussurrato.
Non la signora anziana di quel pomeriggio. O meglio, non solo la signora anziana. Ho intuito i contorni della gonna ma il busto era più massiccio. Le braccia lunghe, le spalle più larghe. La testa calva.
Come quella di mio nonno.
Ho visto l’ombra ribollire come se qualcosa si agitasse al suo interno. Si è allungata verso l’alto ed ero certo di sentire il rumore di ossa che si spezzavano per poi ricomporsi, di pelle vecchia, dura come cuoio, che veniva tirata fin quasi a rompersi
Era più alta, adesso. Potevo vedere persino le mani che pendevano sui fianchi e… mi stava guardando. Sentivo occhi neri che mi fissavano, sentivo che voleva qualcosa da me.
L’ombra ha sollevato un braccio. Una folata di vento ha fatto scricchiolare la siepe rinsecchita, smosso le foglie degli alberi e spinto in casa quel terribile odore di acqua morta. La luce del lampione ha vibrato di nuovo e con orrore ho visto che dita lunghe e nodose, dita da vecchio fatte di tempo e ombra, si stavano allungando sul davanzale, sullo stipite, sulla finestra.
Verso di me.
Ho fatto un passo indietro. Volevo cercare riparo tra le luci dello studio ma l’ombra è riuscita comunque a sfiorarmi.
Ho sentito pelle sottile. Un tocco ruvido ma gentile.
Nonno?
Ma c’era anche qualcosa di sbagliato in quel tocco, qualcosa di ostile. Una rabbia che non comprendevo e che mi terrorizzava. Un desiderio furioso di esistere a ogni costo, una volontà così potente che ero certo mi avrebbe travolto.
Quando l’ombra si è ritirata io ero in ginocchio, per terra. Ho vomitato. Liquore e paura si sono sparsi sul pavimento.
La verità?
Non voglio morire e l’unico modo per farlo è dimenticarmi di aver vissuto. Come le ombre. Un’ombra non sa quando il suo padrone è morto, non sa quando smetterà di essere proiettata.
Devo perdermi per continuare a esistere. E credo di aver capito come fare. L’ho scoperto osservando migliaia di persone che trascinavano il loro dolore lungo il muro del cimitero. Le ho osservate, ho guardato le ombre che ungevano quella parete giallastra con una patina di sofferenza.
Ho dedicato loro così tanto tempo e così tanta attenzione che alla fine si sono accorte di me.
Perché se pensi a qualcosa, se ci pensi davvero, quella cosa inizierà a pensare a te.
E io ti penso. Ti penso tanto.
Tu?
5,
Forse avrei dovuto lasciare la casa quella sera stessa quando ancora potevo, ma non l’ho fatto. Dovevo capire. Dovevo sapere se davvero quell’ombra era mio nonno. Se c’era ancora qualcosa di lui o se l’orrore di un mondo senza luce lo aveva consumato. Pensavo di poterlo aiutare a ritrovare la via di casa.
Così non è stato.
L’ombra ha preso forza ed è tornata mentre io sono sempre più debole. Tre giorni fa mi sono rifugiato in cantina. Il profumo di muffa in qualche maniera riesce a tenere lontano quel terribile puzzo di palude che – ora ne sono certo – è il nuovo odore di mio nonno. Qui ho un po’ di cibo, acqua. Una piccola dispensa. Ma per quanto sarò al sicuro?
Lo sento giorno e notte, al piano di sopra. È entrato in casa e fruga tra quegli scatoloni di un trasloco che non ha mai fatto, tra ricordi che forse non riconosce più, tra le ombre di una vita che aveva smesso di vivere ben prima di morire. È arrabbiato.
E mi cerca.
Sa che sono nascosto qui. Quando si avvicina alla cantina la pelle del braccio brucia. È dove mi ha toccato due settimane fa, quando io ho riconosciuto lui e lui ha riconosciuto me.
Dovrei chiamare aiuto? Forse. Ma forse è meglio di no. Quello che sta succedendo, questi ricordi, queste memorie sono un affare di famiglia ormai. E in famiglia siamo rimasti solo io e il nonno.
Quaggiù ho trovato un tavolino cosparso di mozziconi di candela. Il nonno aveva attrezzato un angolo della cantina come fosse un piccolo studio, una brutta copia della stanza al piano di sopra.
Ci sono delle lettere. Tante lettere che il nonno ha scritto per me. Alcune sono incomprensibili, altre sono così cariche di rabbia, solitudine e dolore che sempre più spesso mi voglia di andare di sopra e abbracciare l’ombra orribile che è diventato. Ma ho paura di quello che potrebbe farmi, della sua collera e del mondo di sofferenza che dice di aver scoperto.
E poi c’è un’altra cosa.
È successo mentre leggevo a lume di candela: proiettata sul muro umido ho visto l’ombra della mia mano. E per un lungo, terribile, inequivocabile attimo, mi è sembrato non fosse mia, quell’ombra.
Erano dita nodose. Da vecchio. Dita di qualcuno che ha abitato questa casa prima di me.


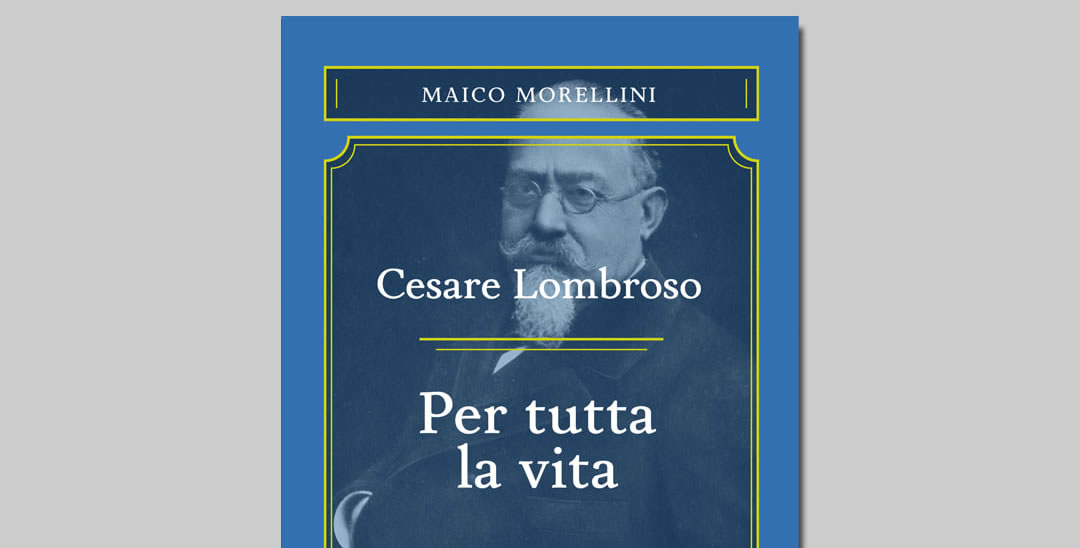
4 Comments
Linda
Grazie per il regalo di Halloween!!!
Un racconto dolce-amaro ricolmo della tua bravura… finito troppo in fretta! Lo leggerò di nuovo
Maico Morellini
Grazie Linda!
Molto contento ti sia piaciuto. 🙂
David
Ispirante a dir poco
Maico Morellini
David, detto da te è un grande, grande complimento.
Grazie! 🙂